Guida alle Differenze tra Recesso, Rescissione, Risoluzione e Disdetta Contrattuale
All’interno del nostro ordinamento, il contratto viene descritto all’articolo 1321 Cod. Civ., come l'”accordo di due o più parti diretto a costituire, regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale“.
Lo scioglimento del contratto può avvenire attraverso diversi istituti giuridici che, sebbene nel linguaggio comune vengano spesso utilizzati come sinonimi, presentano caratteristiche e implicazioni legali profondamente diverse.
Comprendere queste differenze è fondamentale per tutelare i propri diritti e interessi nelle relazioni contrattuali.
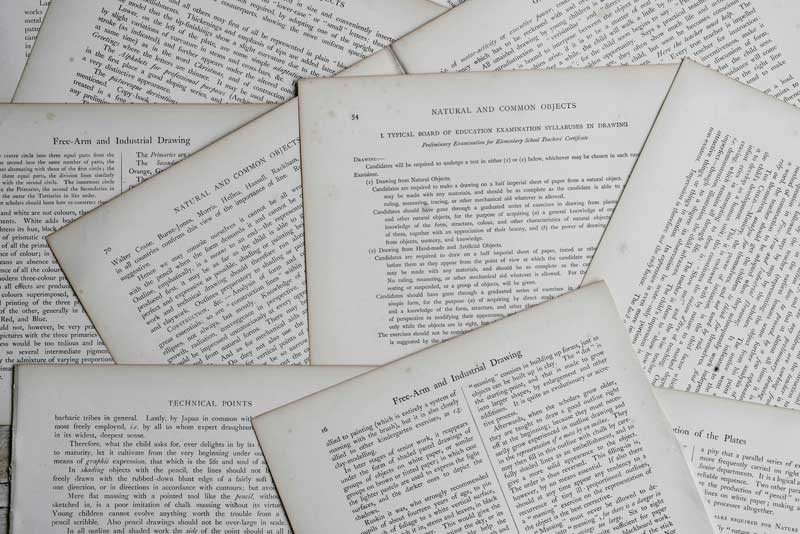
Il Recesso Contrattuale: Interruzione con Effetto Immediato
Il recesso contrattuale è inteso come un atto di volontà di una (cd. recesso unilaterale) o di entrambe le parti per interrompere il contratto con effetto immediato. L’esercizio di questo istituto può essere previsto da espresse previsioni di legge oppure può essere reso possibile tramite l’inserimento di un’apposita clausola nel contratto (cd. recesso convenzionale).
In entrambi i casi, il recesso non ha effetto retroattivo bensì ex nunc, gli effetti del contratto quindi vengono meno dal momento in cui la volontà viene comunicata alla controparte e le prestazioni fino a quel momento erogate andranno restituite.
Inoltre, per il suo esercizio non si richiede l’uso di alcuna formula sacramentale, nonostante questo la Cassazione si è soffermata sul punto con la sentenza 8776/1987 specificando che affinchè il recesso sia esercitato correttamente, la volontà del contraente deve essere espressa e redatta in termini inequivocabili, per non lasciare dubbio alcuno alle altre parti.
La Rescissione del Contratto: Rimedio per Contratti Iniqui
Un altro istituto per ottenere lo scioglimento del contratto è la rescissione, termine che spesso viene ritenuto dall’uomo della strada sinonimo di risoluzione.
In realtà si tratta di un istituto giuridico differente che può essere utilizzato in caso di contratto iniquo ab originem per una delle due parti che è stata portata ad accettarlo per stato di pericolo o stato di bisogno conosciuto dalla parte che ne ha tratto vantaggio. Queste due ipotesi vengono trattate nel nostro codice civile in due disposizioni differenti.
L’articolo 1447 Cod. Civ. prevede la rescissione per stato di pericolo, statuendo che “il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota a controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata“.
I presupposti quindi per esercitarlo sono:
- (i) lo stato di pericolo, inteso come necessità di salvare se stessi o altri da un pericolo attuale e grave alla persona;
- (ii) la conoscenza di controparte dell’esistenza di questo pericolo;
- (iii) l’iniquità delle condizioni accettate.
Successivamente, l’articolo 1448 Cod. Civ. fa invece riferimento alla rescissione del contratto per stato di bisogno, stabilendo che: “se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo contrattato. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione“.
In questo caso quindi i presupposti sono:
- (i) lo stato di bisogno;
- (ii) lo squilibrio tra le prestazioni superiore alla metà;
- (iii) l’approfittamento dello stato di bisogno dalla parte che ne trae vantaggio per ottenere la conclusione del contratto.
Si nota quindi come in entrambi i casi si fa riferimento all’esistenza di un vizio iniziale del contratto che legittima la parte ad agire davanti al giudice per ottenere la rescissione del contratto. A differenza del recesso, quindi, la rescissione contrattuale non può essere fatta da una delle due parti autonomamente ma avviene per via giudiziale. Per quanto riguarda gli effetti, questi sono retroattivi, costituendo un’altra differenza con il recesso.
La Risoluzione del Contratto: Quando il Rapporto Diventa Problematico
Un ulteriore strumento a disposizione delle parti per portare allo scioglimento il contratto è la risoluzione.
Con questa si fa riferimento allo scioglimento del vincolo contrattuale instauratosi tra le parti che può trovare luogo nei contratti a prestazioni corrispettive in tutti quei casi in cui una parte risulti inadempiente, così come nei casi di prestazione divenuta (successivamente alla conclusione del contratto) impossibile, ovvero eccessivamente onerosa.
Può quindi essere esercitata per cause insorte successivamente all’instaurazione del rapporto tra le parti, non conosciute precedentemente.
Questo istituto può trovare luogo di diritto oppure in modo giudiziale.
La risoluzione di diritto può avvenire nei casi previsti dai seguenti articoli:
- (i) 1456 Cod. Civ, il quale prevede la risoluzione per clausola risolutiva espressa, ossia di una clausola contenuta nel contratto che ne prevede la risoluzione automatica al verificarsi di determinate condizioni;
- (ii) 1457 Cod. Civ. in caso di previsione di un termine ritenuto essenziale dalle parti per adempiere e decorso il quale il contratto si ritiene risolto automaticamente;
- (iii) 1454 Cod. Civ. nel quale si prevede il caso di diffida ad adempiere inviata da parte adempiente al contraente inadempiente con l’intimazione a farlo entro una determinata data, oltre la quale il contratto si intenderà risolto di diritto. In tutti questi casi, essendo il contratto risolto automaticamente, la parte non dovrà farne espressa richiesta al giudice.
Laddove non sia prevista una clausola risolutiva espressa, la risoluzione può essere ottenuta attraverso un procedimento giudiziario nei seguenti casi:
- (i) l’inadempimento di una parte contrattuale ex articolo 1453 Cod. Civ.;
- (ii) l’impossibilità sopravvenuta assoluta di adempiere al contratto ex articolo 1463 Cod. Civ.;
- (iii) per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ex articolo 1467 Cod. Civ.
In questo ultimo caso si prevede che l’altra parte possa agire per cercare di evitare la risoluzione tramite la presentazione di una proposta di modifica delle prestazioni contrattuali nel tentativo di renderle nuovamente eque.
La risoluzione quindi, a differenza della rescissione, la si ha nei casi di contratto inizialmente valido ma che per cause sopraggiunte e non precedentemente note alle parti si rivela iniquo. A differenza invece del recesso, gli effetti sono retroattivi, salvo eccezione per i contratti ad esecuzione periodica o continuata nei quali la risoluzione non inciderà sulle prestazioni già adempiute.
La Disdetta: Prevenire il Rinnovo Automatico
Diversamente dagli istituti analizzati precedentemente, questa non incide sul contratto interrompendo il vincolo giuridico in vigore, bensì ne impedisce il rinnovo. Consiste quindi in una dichiarazione volontaria che una delle parti coinvolte rilascia e con cui manifesta la propria volontà contraria al rinnovo di un contratto.
Tendenzialmente i contratti a tacito rinnovo prevedono l’obbligo di comunicare la disdetta entro un determinato termine precedente alla scadenza. Per esempio, se si volesse disdire un contratto di locazione su un immobile adibito ad uso abitativo, la legge prevede che questa debba essere comunicata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 6 mesi dalla data di fine prevista del contratto, diversamente per gli immobili ad uso commerciale entro 12 mesi.
Forse ti può interessare quest’altro articolo sulla differenza di tutele per il deposito cauzionale e la caparra confirmatoria.